ATTRAVERSO IL CILENTO. UN VIAGGIO NELL’OTTOCENTO DELL’INGLESE RAMAGE
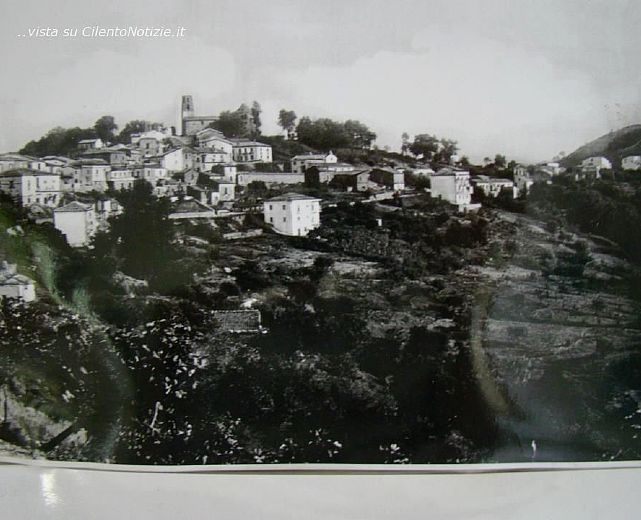
 di Giuseppe Lembo | Blog
di Giuseppe Lembo | BlogIL CILENTO TERRA DEI MITI E DI
PROFONDA ED ATAVICA MISERIA
Nell’ottocento, tra mille difficoltà, il Cilento fu attraversato da viaggiatori stranieri, attivi protagonisti del Gran Tour in Italia.
Il Cilento regione della Campania meridionale compresa tra il Tirreno ed i rilievi occidentali dell’Appennino campano, un tempo era una Terra amara; una Terra dei tristi; era impervia e di difficile accesso.
Scarsa la sua popolazione. Fu abitata dai Lucani; in alcune parti della costa si insediarono delle colonie greche.
Nel IX secolo per effetto di scorrerie saracene si ha la distruzione di Velia e di Paestum; si ha, altresì, un crescente e diffuso impoverimento dell’intera regione Cilento.
Nel X secolo, ad opera dei Benedettini si assiste ad una sua rinascita.
Saranno i Sanseverino a governare per molti secoli il Cilento; il territorio cilentano con il governo dei Sanseverino riuscì a godere di prosperità ed anche di una certa comune tranquillità.
Verso la metà del XVI secolo con la fine dei Sanseverino e la confisca della baronia, il Cilento conobbe di nuovo condizioni di assoluta arretratezza; condizioni di povertà diffusa; condizioni di profondo degrado umano e sociale della sua popolazione divisa e sfruttata da tanti piccoli feudatari, dei veri e propri ras locali, disumanamente impegnati a tartassare il popolo.
Le condizioni di miseria e di sottosviluppo continuarono anche sotto i borboni, nonostante i provvedimenti in favore della gente cilentana da parte di Giuseppe Bonaparte e di Giocchino Murat.
Durante il Risorgimento nel Cilento scoppiarono ben due insurrezioni (del 1828 e del 1848), entrambe finalizzate ad ottenere istituzioni rappresentative; tanto, per uscire dalla miseria, cambiare stato e per vivere in condizioni umanamente migliori.
Mentre fallì miseramente la prima, la seconda del 1848 costrinse Ferdinando II a concedere la Costituzione.
Nel Cilento si consumò, tra l’altro, nel 1857 la sfortunata spedizione di Carlo Pisacane.
In questo Cilento, fatto di degrado, di abbandono, di indifferenza e di tanta disumana miseria, soprattutto per il suo popolo da sempre senz’anima, con al centro della scena feudatari sempre più avari ed avidi del possesso delle cose, in agguato a succhiare il sangue della povera gente, frastornato dalla sua sempre disperata solitudine, nel corso dell’ottocento, si avventurarono numerosi viaggiatori, spinti soprattutto dal senso del proibito e dalla forte voglia di scoprire riti e credenze del mondo antico e tutte quelle testimonianze etno-antropologiche legate a lontane sopravvivenze linguistiche e della cultura materiale nell’area fortemente diffusa.
Le loro memorie di viaggio, hanno oggi per tutti noi, un valore oltre che storico, soprattutto socio-antropologico; un valore che va molto al di là della semplice testimonianza.
Ci serve e tanto, per riannodare i fili spezzati e per conoscere il comportamento umano di un passato ormai lontano, utile al fine di cercare di cambiare il nostro presente e pensare ad un futuro nuovo con un popolo rigenerato e non più vittima rassegnata di una sudditanza silenziosa che ha portato il Cilento fino ad oggi, al suo profondo sottosviluppo ed alla sua assordante incapacità di cambiare, non avendo alla base quella forza di coesione d’insieme, che è il presupposto della comune opera dell’uomo di tutti i tempi, per costruire da protagonisti con le proprie mani il futuro, come prodotto d’insieme.
Il libro di cui oggi credo assolutamente importante occuparmi è del letterato scozzese Craufurd Tait Ramage, cultore di lingue classiche e precettore dei figli del Console inglese presso la Corte di Napoli.
Nell’aprile del 1828, intraprese un viaggio nel Regno delle Due Sicilie, per rintracciare nei dialetti del Regno delle Due Sicilie, sopravvivenze linguistiche e culturali greco-latine.
Il libro di Ramage “Attraverso il Cilento” il viaggio di C.T. Ramage da Paestum a Policastro nel 1828, è parte di quel più ampio viaggio nel Regno delle Due Sicilie, pubblicato a Liverpool nel 1868 con il titolo inglese Ramage in south Italy – The nooks and by-ways of Italy - Wanderings in search of its ancient Remains and modern superstition.
È stato oggi, intelligentemente riproposto nell’edizione italiana, limitatamente al Cilento, dalle Edizioni dell’Ippogrifo, una casa editrice salernitana con sede ad Angri, attivamente impegnata a promuovere il Sud attraverso i libri, fonte di sapere che, in quanto tale, fanno la differenza, mettendo prima di tutto al centro quelle problematiche socio-antropologiche, culturalmente importanti per poter cambiare le amare condizioni di un Mezzogiorno maledetto, storicamente sedotto ed abbandonato dai tanti che, non amandolo come terre dei miti, hanno pensato sempre e solo a sfruttarlo, creandone le condizioni tristi e di invivibilità diffusa che, per tanti versi, ora come allora, rappresentano il comune e consolidato denominatore della Terra dei tristi, come Terra “sedotta ed abbandonata”.
Assolutamente non entro nei dettagli del viaggio di Ramage; non lo faccio per evitare di anticipare emozioni tutte da vivere leggendo attentamente pagina per pagina quanto l’autore ha visto visitando il Cilento circa due secoli addietro (per la precisione 185 anni fa).
Ramage, come scrive nell’introduzione Raffaele Riccio, era spirito libero, animato, tra l’altro, dal coraggio dal sapore avventuroso di scoprire come viveva la gente abbandonata del Sud, dove c’era una forte presenza endemica di tristi conosciuti come briganti, con strade mulattiere per soli pedoni e/o per asini da soma.
Una terra fuori dal mondo senza ospedali e con la sola ospitalità possibile presso gli abitanti dei luoghi visitati, appartenenti soprattutto ai pochi ceti colti.
Lo spirito di Ramage esploratore era animato soprattutto dalla forte curiosità del viaggiatore antropologo e filosofo attento a conoscere i resti archeologici e linguistici della Magna Grecia e di Roma.
Nel Cilento, proprio da Paestum a Sapri, Ramage, ha il suo incontro con il primo Sud di cui ne racconta gli aspetti soprattutto umanamente più significativi, affidandoli alle suggestioni della memoria del tempo, che ne farà tesoro, restituendoci l’atmosfera di un Cilento e di un Sud che non smette mai di emozionarci, grazie anche alle testimonianze di questi generosi ed arditi pellegrini dell’avventura, che sapevano saggiamente affidarsi ai loro taccuini di viaggio dove registravano scrupolosamente le complessità delle sensazioni vissute e condivise con la gente dei luoghi visitati.
Ma oltre all’umanità cilentana a Ramage interessò e non poco il paesaggio e le bellezze naturali; ogni parola va oltre il suo più intimo significato; in esse c’è il profondo interesse di un artista, pittore più che scrittore; l’anima narrante affida le sue emozioni alle parole cariche, tra l’altro, di vive suggestioni cromatiche.
L’attenzione di Ramage viaggiatore diventa forza narrante animata da viva partecipazione emotiva per tutte le cose viste.
Anche se volutamente evito le citazioni, qualche passaggio, mi sembra assolutamente opportuno farlo.
A proposito dell’alimentazione delle classi lavoratrici, nell’incontro con un contadino nei pressi di Velia, Ramage scrive: “Dopo poco mi imbattei in un contadino che mangiava insieme alla moglie, al figlioletto ed all’asino e non potei fare a meno di pensare, osservando il loro miserevole cibo, che l’asinello era forse quello che se le passava meglio. Il loro desinare consisteva in un po’ di pane rozzo ed un fiasco di vino che si dimostravano pronti a condividere con me ….”.
Il cibo povero e le fatiche nei campi delle classi meno agiate determinavano anche la perdita precoce della giovinezza; tanto è quanto andava ripetendosi il nobile inglese nel conoscere le tante e diffuse povertà cilentane, espressioni umane di un popolo antropologicamente, fortemente primitivo.
Quello descritto da Ramage è un Cilento certamente diverso da come lo percepiamo noi oggi; ma nonostante le diversità per i cambiamenti nei luoghi e nelle condizioni antropiche delle persone, ci sono tratti umani che ancora oggi riflettono quell’unicuum di immutabilità presente e fortemente determinata nell’umanità cilentana, anche se sono evidenti i segni delle tante variabili sopravvenute nel corso del lungo tempo trascorso.
Sono tante le impressioni di questo viaggio di Ramage attraverso il Cilento.
A proposito delle case “ …. Le case presentavano un aspetto poco curato che ricordava, anche troppo, le condizioni delle persone alle quali appartenevano”.
A proposito della natura e delle Terre coltivate “I monaci curano, o meglio curavano, con grande impegno i loro frutteti e ne ottenevano in ogni stagione frutti di gran pregio.”
Ramage ritrova Columella quando scrive “ Tunc praeco bifera discendit ab arbore ficus” e Virgilio quando parla dei “bis pomis utilis arbos”
A Paestum Ramage sarà ospite di una locanda che così descrive: “La mia stanza da letto si trovava all’altezza della prima rampa di scale; in essa vi erano alcune assi ed un pagliericcio che servivano da letto …”.
Ad Agropoli nei pressi dell’abitato Ramage vede a distanza delle signorine “… erano indaffaratissime a lavare i panni in un ruscello, con le vesti tirate su, fin sopra le ginocchia; non mi avvicinai per non disturbarle. Si dice, ma non so quanto sia vero, che le ragazze qui possono sposarsi all’età di dodici anni, possibilità dovuta alla mitezza del clima”.
A proposito della buona ospitalità cilentana, una caratteristica antica presente anche nel Cilento dei nostri giorni, Ramage ci racconta: “… quanto mi veniva offerto sembrava un cibo scarso e grossolano, ma era evidente che veniva donato con buon cuore e questo avrebbe compensato largamente anche l’offerta di vivande di qualità più scadente”.
Qui Ramage assapora l’olio e le salsicce di cui parlava Cicerone quando scrive: “ solebam antea delecta oleis et lucanicis tuis (solevo deliziarmi delle tue olive e delle tue salsicce)”.
Oltre a queste nel Cilento riscontra anche la presenza dei fichi secchi. Questi, dice Ramage, sono quelli che i Romani chiamavano caricae tenuti in così alta considerazione da essere considerati cibo degno degli dei.
Si trovava a Torchiara: … “dato che mi era nota l’eccitabilità del temperamento meridionale, m’aspettavo che da un momento all’altro estraessero i coltelli”.
A proposito del mondo contadino Ramage scrive: “I contadini italiani sono gente felice ed allegra e di poche pretese; ignorano quei lussi che da noi sono ormai diventati necessari, per la gente di qualsiasi ceto; questi, invece, vivono perfettamente soddisfatti con il poco che possiedono”.
È veramente carico di amore per il bello naturale quanto Ramage scrive: “ Non sono poi tanto soggiogato dalla mania per le antichità da non riconoscere che un panorama così vario, come quello che ora stavo ammirando, non parli con più eloquenza al cuore e non abbia un influsso morale superiore a qualsiasi opera, per quanto magnifica, costruita dall’uomo, anche se questa testimonia una delle pagine più luminose della storia dell’umanità”.
Il senso di rispettosa ospitalità cilentana è evidenziato più volte da Ramage.
Nelle sue descrizioni della gente dei luoghi attraversati, Ramage si sofferma con dovizia di particolari; descrive, tra l’altro, l’aspetto delle donne, indicandone le loro caratteristiche.
“Alcune di loro erano ancora giovani, ma l’esposizione costante al sole e il lavoro faticoso nei campi, avevano solcato di rughe le loro facce ed avevano provocato sui volti un’apparenza di vecchiaia, non corrispondente alla loro età”.
Ramage si innamora e non poco del Cilento di cui condivide compiaciuto tutto.
A tal proposito scrive: “Tutto ciò che ho potuto osservare di questa gente mi piace; nulla può superare la bontà, la cortesia e l’ospitalità dimostratami senza distinzione, da tutti quelli che ho avvicinato; per di più, anche se non avessi visto null’altro all’infuori del tramonto dalla cima del Monte Stella, mi considererei pienamente ripagato di tutti i disagi che ho fin qui sostenuto”.
Con questo esaltante suo pensiero per la Terra cilentana, chiudo il mio breve percorso di stimolanti citazioni, così come contenute nel libro.
Leggerle è un vero e proprio viaggio nel viaggio; un viaggio che, pagina dopo pagina, suscita tante diverse e forti emozioni e fa scoprire tanti aspetti sconosciuti della gente cilentana, gente povera, ma ricca di umanità e di grande disponibilità verso gli altri; verso i forestieri, come Ramage, che rompendo il profondo ed assordante silenzio di un sempre dalle radici antiche, hanno calpestato la Terra cilentana, per confrontare le testimonianze di un lontano passato, in un presente dalle caratteristiche completamente mutate.
Due sono le cose che Ramage ha più gradito attraversando il Cilento; una di natura antropica e riguarda la profonda umanità cilentana, un’umanità aperta verso gli altri, con un senso di ospitalità amica assolutamente difficile da trovare altrove; l’altra è la dolcezza della natura, con un paesaggio che, come lui ci dice, ripaga l’ospite di tutti i disagi a cui va incontro.
Un viaggio antropologicamente interessante; certamente Ramage non è un viaggiatore distratto e/o indifferente alle cose viste.
Si sofferma attentamente su tutto e per tutte le cose viste e/o le umanità incontrate, fa le sue intelligenti osservazioni socio/antropologiche, naturalistiche e di appartenenza linguistica.
Questo libro di viaggio, attraverso il Cilento, letto con la dovuta attenzione, può sicuramente arricchirci di nuova ed utile conoscenza; può sicuramente meglio aprirci le porte alla comprensione di un’umanità cilentana che non teme paragoni in termini di generosa disponibilità verso gli altri.
Può ed è questa la cosa più importante, illuminarci sul nuovo possibile cammino del Cilento, ricco di storia, di tradizioni, di un nobile passato di saperi, di testimonianze e di tanta umanità profonda che, accompagnandosi al lungo cammino umano, nel corso dei secoli è arrivato fino a noi; è oggi parte di noi e sarà sicuramente anche parte di quelli che verranno, sempre che il Cilento, facendosi violenza, non cancelli il meglio di se stesso nelle due cose riconosciute da Ramage, parti insostituibili della grande ricchezza cilentana.
L’umanità della gente e la bellezza della natura, sono le due cose di cui, a prima vista e nel profondo dell’anima si innamorò Ramage; sono le due cose che questo nobile pensatore inglese, viaggiando per le vie impervie e sgarrupate del Cilento, ha descritto sognando e scrivendo per noi suoi lettori che, commossi e con animo grato, gli diciamo grazie, pensando insieme alla rigenerazione del Cilento che ci auguriamo non perda, cammin facendo le sue virtù, ossia i suoi grandi beni, fatti di uomo e di natura, da sempre armonicamente e felicemente insieme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA








