La scuola di Bianchi fra sogno e realtà
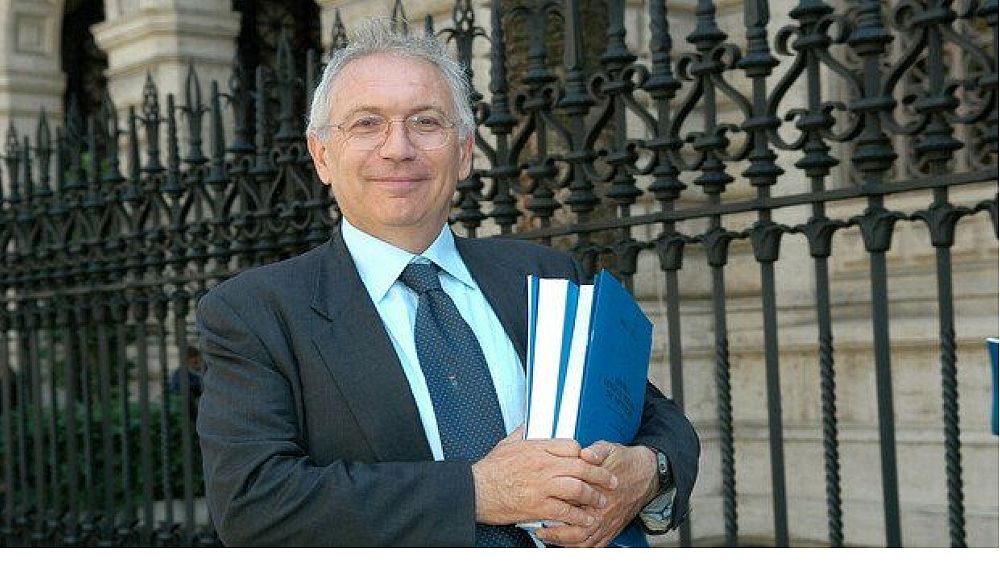
Generalmente il sognatore è una persona che insegue un proprio mondo di aspirazioni e di ideali illusori e inconsistenti. Patrizio Bianchi, l’attuale Ministro dell’Istruzione, è po’ sognatore, ma nel sollecitare l’attenzione alle sue sequenze sognanti, si limita all’uso di una sola benda per occhio, magari in raso nero, un po’ come quella di Barbanera, pirata del lontano XVII secolo, su cui sono circolate più leggende in assoluto. E poi, bisogna riconoscere, malgrado tutti i bonari fantasiosi accostamenti, resta sicuramente ben saldo, coi piedi ben puntati per terra. Con la sua formazione e la sua esperienza, viva Dio, arricchisce qualitativamente, finalmente, gli scranni della politica romana e, dopo un lungo periodo buio, ridona vigore ed entusiasmo nell’eclettico palazzo novecentesco del Ministero dell’Istruzione, in via Trastevere, richiamante “lo bello stilo” dell’architettura rinascimentale e barocca voluta dall’accademico Bazzani.
E’ un sognatore romantico che vede il bello della scuola, una scuola tutta fatta gradevole, capace di suscitare impressioni piacevoli e sulla quale poter scommettere per il futuro. E’ più sogno o manifesto futurista, ricalcando le orme, per altro verso, di Filippo Tommaso Marinetti?! Se Patrizio Bianchi è più sognatore, quasi sicuramente lo è in linea al termine francese “réverie”, introdotto da Bion, nel saggio “Apprendere dall'esperienza”, per indicare lo stato mentale aperto alla ricezione di tutto ciò che proviene dall'oggetto amato; resta quindi sicuramente padrone del suo fantasticare, non certo passivo, vittima di un suo lato inconscio che può rivelare di lui anche elementi che preferirebbe non conoscere.
Il nostro Bianchi sognatore, in effetti, ha quasi disegnato la nuova scuola, manifestando desideri e attese. “Mi piacerebbe, dichiara, che nella nuova normalità i ragazzi di una scuola di Napoli possano condividere le loro attività con una scuola del Piemonte, oppure che le scuole di Napoli, di Milano o di Palermo, possano condividere attività con una scuola di Dusseldorf, di Praga o di Bratislava. Mi piacerebbe che i nuovi strumenti possano essere usati con la coscienza di avere nuovi strumenti, per cui io so scrivere – e saper scrivere è importante perché significa avere il controllo della parola – ma so usare anche un video, l’immagine, il suono, la musica. Vorrei una nuova normalità fatta di un Paese più conscio di quello che siamo, dei limiti, ma anche delle capacità. Vorrei una scuola più capace di sentirsi il centro della nostra comunità nazionale. Vorrei una scuola in cui non soltanto la sicurezza dei corpi, ma delle persone fosse diffusa e condivisa. Vorrei una nuova normalità, che sia per tutti, in cui tutti i ragazzi del nostro Paese, in qualsiasi posto abbiano avuto le proprie origini, sentano di avere gli stessi diritti e si sentano capaci di diventare anche portatori degli stessi doveri”.
Il Ministro Bianchi vuole una scuola aperta, abile nel rendere attivo l’imparare vedendo, facendo, operando. In prospettiva di settembre ritiene che bisogna camminare verso “una normalità in presenza in cui però useremo tutti gli strumenti finora adoperati, perché non si butta via quello che abbiamo fatto”. Sarà sicuramente una presenza nuova, divergente rispetto al passato ove però bisognerà garantire le dinamiche della condivisione e della socialità. Ritrovarsi fisicamente, nel luogo deputato alla formazione e alla crescita, servirà a riscoprirci in una socialità aperta, dinamica, costruttiva.
“Apriremo un cantiere per la scuola del futuro. Il futuro siamo noi, dice Bianchi, lo stiamo costruendo insieme, vedendo le orme su cui siamo passati e lasciandone di nuove per chi verrà dopo. La Dad ci ha insegnato che ci sono altri modi e che ci sono altri mondi. Possiamo usare quell’esperienza come base, trarne vantaggio, ricordandoci come è nata questa cosa. Abbiamo iniziato a usarla come alternativa all’abbandono, come modo per i ragazzi di restare collegati alla scuola. Perché l’alternativa era non fare lezione. Abbiamo commesso l’errore di replicare a distanza quello che avveniva in presenza, di replicare il rapporto docente-studente mettendoci in mezzo un computer. Solo che così non va bene, perché dobbiamo usare gli strumenti, non essere usati. In questo momento, tutti gli studenti della scuola dell’obbligo sono nati in questo secolo, mentre più o meno tutti gli insegnanti sono nati il secolo scorso. Sono loro che hanno bisogno di formazione. Bisogna incrociare le competenze, pensando a un reskilling degli adulti, a una scuola che continua e non finisce, che inizia prima dei 6 anni e va avanti dopo i 18. Dobbiamo combattere l’abbandono scolastico, perché non è possibile che in alcune zone dell’Italia arrivi al 30%. Vogliamo mettere in sicurezza gli edifici, in cui abbiamo investito 1,25 miliardi di euro. Voglio una scuola nazionale!”. Le competenze, lascia intendere il Ministro, in una “scuola nazionale” dovranno essere condivise su larga scala in ogni posto della penisola. Dobbiamo realizzare, aggiunge, una scuola senza paura degli strumenti moderni, perché fra noi e gli smartphone, siamo noi che dobbiamo essere smart.
“Conto molto sulla vaccinazione di massa dei ragazzi, ammette il Ministro, che è importante”. Intanto salpiamo, leviamo le ancore e prendiamo il largo con la Scuola d’Estate. “La scuola d’estate fa parte della mia idea, prosegue, appartiene al sogno di una scuola che non finisce, che continua a formare sia chi insegna, sia chi riceve l’insegnamento. Fa parte della mia idea di una scuola che tenga le competenze il più fluide possibile, il più interconnesse possibile”. Intanto, a seguito di un confronto internazionale, l’istruzione universitaria e il mondo della scuola nel nostro Paese escono perdenti. Il Paese è in ritardo e procede con affanno, se pure in presenza di talune eccellenze. La scuola italiana, nel quadro europeo, procede con lentezza, fatta eccezione per i suoi programmi di studio (l’ateneo romano de La Sapienza si è infatti piazzato al primo posto mondiale); la nostra scuola però rimane in affanno per la scarsa proiezione internazionale, il basso numero di docenti in rapporto a quello degli studenti, il cronico sottofinanziamento del sistema universitario, lo scarso finanziamento della ricerca. Sono queste le principali cause di affaticamento del sistema scuola. Non ci resta che sperare, già a partire dalla Scuola d’Estate che si realizzino i sogni di Bianchi. Sarà una scuola agostana fatta anche, a700 anni dalla morte, di riflessione sul pensiero, sugli scritti e sull’eredità di Dante. In tal senso possiamo ben sperare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA









